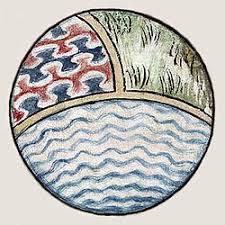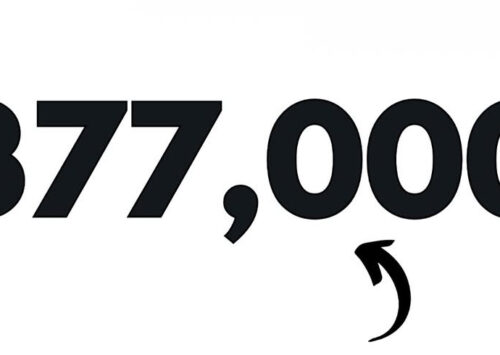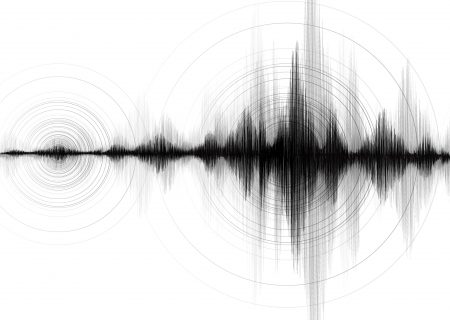Siamo entrati in una fase storica in cui la fragilità, a lungo negata, torna a manifestarsi come verità profonda della condizione umana. In un sistema ancora dominato da logiche industriali, parlare di 'fragilità' suona quasi stonato. Eppure è proprio da qui che si può iniziare a trasformare il paradigma che ha scandito la storia delle rivoluzioni industriali (meccaniche) iniziate alla fine del '700 e giunta fino ad oggi (...in realtà, fino a ieri).

Industria 1.0 – Meccanizzazione (1780)
L’umanità si affida alle macchine mosse da acqua e vapore. Nasce il mito della forza. L’uomo non è più contadino o artigiano, ma ingranaggio.
Industria 2.0 – Elettrificazione (1870)
L’energia elettrica e le catene di montaggio portano la produzione di massa. Il tempo si linearizza, lo spazio si segmenta.
Industria 3.0 – Automazione (1970)
L’elettronica e i computer automatizzano il lavoro. L’intelligenza umana viene decentrata, la relazione uomo-macchina si fa subordinata.
Industria 3.5 – Globalizzazione (1980)
La produzione si delocalizza, la logica del profitto si espande a livello planetario. L’umano è sempre più escluso, disperso, sostituibile.
Industria 4.0 – Digitalizzazione (oggi)
I big data e l’intelligenza artificiale entrano ovunque. L’automazione diventa predittiva, la sorveglianza è incorporata, e il corpo è ridotto a comportamento tracciabile.
Industria 5.0 – Personalizzazione (futuro prossimo)
Annunciata come “umanocentrica”, vuole reinserire l’uomo nel processo produttivo tramite collaborazione con robot, AI e cognitive computing. I lavoratori verranno “potenziati” per creare prodotti personalizzati e “resilienti”.
Nel vocabolario tecnico, la resilienza è una proprietà dei metalli: la capacità di assorbire un urto e tornare alla forma originaria. Ma l’essere umano non è acciaio. È materia organica, biologica, vivente. È coscienza, relazione, memoria e spiritualità.

Trattare l’umano come un materiale da rendere “resiliente” è un inganno raffinato. Ci vogliono robusti, adattivi, performanti anche nella crisi. Ma così ci mantengono in funzione dentro il sistema, non oltre il sistema.
Nel pensiero sferico, l’umano non è un metallo che resiste. È un essere poroso che cresce attraverso le crepe, che si trasforma nel trauma, che evolve grazie all’imprevisto. Questa è la vera antifragilità: non tornare com’era prima, ma diventare qualcosa di nuovo grazie alla crisi. Come scrive Nassim Taleb: “L’antifragile ama il disordine e l’incertezza; è proprio ciò che lo rende migliore”.
Industry 5.0 tenta un salto qualitativo: parla di cooperazione uomo-macchina, di benessere personalizzato, di sostenibilità e resilienza. Ma lo fa ancora da dentro il paradigma produttivo, lineare, tecnocratico.
Nel Movimento dello Sferismo, invece, si cambia geometria. Non più industria lineare, gerarchica, centralizzata.Ma sistema sferico, simmetrico, interconnesso, poetico. L’economia sferica non misura l’efficienza, ma la bellezza delle relazioni. Non valuta il “valore aggiunto”, ma l’equilibrio rigenerato. Non cerca personalizzazione, ma unicità in risonanza con il tutto.

La fragilità non è un limite da superare. È una soglia da abitare. Non dobbiamo tornare resilienti. Dobbiamo aprirci all’antifragilità trasformativa.
L’Industria 5.0 prova a rendere l’umano “compatibile con la macchina”.
Lo Sferismo ci invita a renderci compatibili con la Vita.
Il futuro non è una catena di montaggio più umana. È una danza cosmica in cui ogni punto della sfera conta